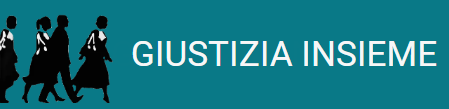Diario dal Consiglio del 4 ottobre 2025
Il CSM fuori dalle scelte sull’IA nella giustizia?
Nella seduta del 24 settembre, il Plenum ha emesso il parere ex art. 10 l. n. 195/1958 sul disegno di legge delega in materia di intelligenza artificiale (IA), di iniziativa governativa, ora licenziato dal Parlamento come legge 23.9.2025, n. 132.
La legge italiana si affianca al Regolamento UE 2024/1689 (c.d. “AI Act”), che disciplina la commercializzazione e l’uso dell’IA in maniera uniforme negli Stati membri, e mutua da tale Regolamento i principi fondamentali affidati al legislatore delegato, corredandoli di varie norme di dettaglio. Soprattutto, la legge delega definisce l’architettura del sistema nazionale di governance e disciplina la fase di sperimentazione.
Il parere consiliare si sofferma essenzialmente sulle implicazioni della legge delega per l’amministrazione della giustizia.
Gli aspetti di maggiore interesse per il Consiglio si rinvengono negli articoli 15 e 20, che, per un verso, tipizzano gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria – individuandoli nella “organizzazione dei servizi relativi alla giustizia”, nella “semplificazione del lavoro giudiziario” e “nelle attività amministrative accessorie” – e, per altro verso, identificano i soggetti istituzionali preposti alla regolamentazione e alla governance di tali sistemi e alla formazione degli operatori.
Nel parere si evidenzia con nettezza come il disegno di legge non coinvolga in alcun modo il CSM nella disciplina e nella governance dell’impiego dell’IA nell’attività giudiziaria e si reclama con fermezza il posto che compete all’Organo di governo autonomo della magistratura nella cabina di regia dell’IA nel settore della giustizia (p. 34 ss. del parere).
A prescindere dal rilievo che la disciplina dell’impiego dell’IA “per la semplificazione del lavoro giudiziario” implica un intervento che è quanto meno problematico ricondurre al perimetro delle competenze assegnate al Ministro della giustizia dall’art. 110 Cost. (“l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”), è evidente che molte attività di supporto alla giurisdizione non sono neutre rispetto all’esercizio di quest’ultima, ma, così come evidenziato in Plenum da Antonello, vi incidono in maniera diretta e costante: si pensi, ad esempio, ai meccanismi di distribuzione degli affari (e alla garanzia costituzionale del giudice naturale), alla definizione dell’ordine di priorità, alla predisposizione delle tabelle.
Quanto alla governance dell’IA, è preoccupante che l’articolo 20 preveda, quali unici interlocutori istituzionali del Ministero, due agenzie governative, l’AgID (digitale) e l’ACN (cybersicurezza), che non sono autorità amministrative indipendenti, bensì agenzie non indipendenti; gestendo interessi e attività di rilevanza strategica, esse sono sottoposte a un marcato controllo politico e agli indirizzi dettati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri (o dal Ministro delegato), che peraltro ne nomina i vertici.
Al riguardo, il parere evidenzia criticamente come il settore giustizia risulti così sottoposto al controllo di agenzie prive delle specifiche garanzie costituzionali di indipendenza richieste per il governo della giurisdizione e che, per di più, AgID e ACN siano anche gli unici soggetti che il Ministero è tenuto a sentire prima di autorizzare la sperimentazione dei sistemi di IA, nella fase transitoria che precede la compiuta attuazione del Regolamento UE (art. 15, co. 3). Questo è un compito cruciale, dal momento che le prime sperimentazioni influenzeranno e orienteranno, inevitabilmente, tutti gli utilizzi successivi, con il rischio che si consolidino prassi inadeguate e usi impropri.
Ulteriore criticità evidenziata nel parere è quella per cui la promozione di attività didattiche sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria risulta affidata dalla legge (art. 15, comma 4) esclusivamente al Ministero della giustizia, nell’ambito dell’elaborazione delle linee guida dal medesimo dettate alla Scuola superiore della magistratura ex art. 12, co. 1, lett. a, d.lgs. 30.1.2006, n. 26, senza alcuna considerazione del ruolo che in tale materia andrebbe riconosciuto alle diverse linee guida che, ai sensi dalla medesima disposizione, anche il CSM deve assegnare alla Scuola.
Il dibattito sul parere in Plenum è stato denso di suggestioni e riflessioni sulle potenzialità e i rischi legati all’impiego di sistemi di IA nell’amministrazione della giustizia, che è presente in misura sempre più pregnante nella quotidianità degli operatori. Tra i temi toccati, spiccano quelli della prevedibilità delle decisioni e dell’importanza del momento di valutazione umana nel processo decisionale.
Molto censorio l’intervento della consigliera laica Bertolini, che ha etichettato il parere come “inutile”, perché privo di indicazioni concrete. Secondo Bertolini, il Consiglio avrebbe dovuto compiere una ricognizione dei sistemi di IA già in uso presso gli uffici giudiziari italiani e dei progetti di sperimentazione avviati, presentando proposte pratiche migliorative e non solo rilievi critici.
Rispettiamo il punto di vista della consigliera Bertolini, ma difendiamo con decisione le scelte della Sesta commissione, fatte proprie dal Plenum, che ha approvato il parere con 5 astensioni (il togato Mirenda e una compagine di alcuni dei laici espressi dalla maggioranza governativa – il VP Pinelli, Bertolini, Bianchini, Eccher).
Riteniamo, infatti, che, nell’esercizio della sua funzione consultiva rispetto a un procedimento legislativo in corso, il Consiglio abbia il compito di evidenziare l’impatto della novella sull’amministrazione della giustizia, di segnalare eventuali ambiguità e dubbi interpretativi e di vigilare affinché siano rispettate le competenze e prerogative istituzionali dei diversi soggetti chiamati dalla Costituzione a collaborare nell’amministrare la giurisdizione. Le proposte concrete potranno trovare spazio, semmai, in un secondo momento, se, nel caso specifico, al CSM sarà riconosciuto un posto al tavolo dell’IA nel settore della giustizia; tavolo a cui, ad oggi, siedono solo il Ministero della giustizia e le due agenzie governative AgID e ACN.
Il CSM, d’altra parte, è interlocutore privilegiato delle figure impegnate in prima linea nell’informatizzazione degli uffici (RID e MAGRIF), con cui la Settima commissione e la STO intrattengono un proficuo e costante dialogo. Ci pare del tutto irragionevole che la legge non valorizzi un patrimonio conoscitivo che costituisce il frutto del circolo virtuoso che lega CSM, RID e MAGRIF e che sarebbe di particolare utilità per calibrare l’innovazione tecnologica dell’IA in relazione alla concreta esperienza degli uffici. Così come ci pare necessario garantire un apporto istituzionale dell’Avvocatura nei processi decisionale relativi all’impiego dell’IA nel settore della giustizia. La prospettiva di tutti gli operatori del processo appare, infatti, fondamentale al fine di comprendere appieno i risvolti dell’utilizzo dei sistemi di IA nel concreto e quotidiano espletamento dell’attività giudiziaria, nonché le possibili controindicazioni dell’innovazione.
Il legislatore, indefinitiva, ha addossato al solo Ministero della giustizia l’enorme responsabilità di fornire prodotti di IA sicuri, che rispettino la riservatezza e che siano al tempo stesso performanti per gli usi di giurisdizione. Anche a prescindere dalla questione della coerenza di questo assetto con l’articolo 110 della Carta costituzionale, non ci pare che escludere magistratura e foro dall’elaborazione su questo tema sia una buona scelta
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello